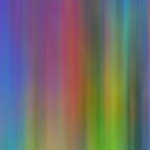Nella strofa finale di Grace, struggente e disperata canzone sulla maniera in cui ci si congeda dalla vita, la voce strozzata e urlante del compianto cantautore americano Jeff Buckley ammette che “I feel them drown my name so easy to know and forget with this kiss“(lì sento soffocare il mio nome, così facile da conoscere e da dimenticare con questo bacio), parole che, trascendendo dall’intensità dell’interpretazione, sintetizzano in maniera assoluta ed efficace il concetto di grazia, una qualità rara e difficile da identificare, che contiene in sé l’idea di dolcezza e di abbandono espressa dai versi di Buckley.
Le stesse parole si adoperano con altrettanto adeguatezza per spiegare la sensazione che pervade e trasmette questo lavoro di Eric Rohmer, un signore ormai arrivato a quota ottantasette anni, che continua a possedere una freschezza, una vivacità e una sensualità del tocco in grado di dare al suo cinema un’anima al contempo profondamente giovane e arcaica. L’accostamento seppur azzardato risulta ancora più pertinente se si pensa che annegamento, identità di nome e di genere e il valore del bacio sono elementi narrativi e simbolici fondamentali nel romanzo scritto nel XVII secolo da Honorè D’Urfè e da cui Rohmer, dopo essersi confrontato con Von Kleist (La Marquise Von O) e Chrétien de Troyes (Perceval le Gallois), prende spunto per proseguire la sua indagine sul mondo dei sentimenti, delle relazioni umane e dei conflitti etici e morali che il vivere nel nome del Dio Amore comporta. Tutta questa ricerca si nutre di un valore filosofico e morale astratto quando si appoggia alla parola poetica e letteraria, oltre che alla forma cantata, il triplice linguaggio su cui si articola l’opera di D’Urfè ambientata nella Gallia del V sec d.c. abitata dal popolo pagano dei Druidi, in un contesto che non si preoccupa di definirsi storicamente o geograficamente, quanto più a livello di suggestione paesaggistica ed emotiva, un luogo dell’immaginazione e del mito.
L’intreccio della trama si basa su una struttura semplice e infallibile, con i due pastorelli Astrea e Celadon che un equivoco e una gelosia indotta in lei da un corteggiatore invidioso sembrano separe per sempre, con la finta morte di lui,l’intervento del Deus ex machina nelle visti di un principe Druido e la sua generosa nipote, il travestimento e il ricongiungimento finale. Ma ciò che conta in Rohmer sta altrove, nel sentire e nel far sentire le vibrazioni, le piccole implosioni, le scelte e le domande che pone la coscienza, sottoponendo le pulsioni del cuore e della carne ad un’analisi razionale di pacata saggezza e intelligenza assegnando all’arte, ma anche all’artificio della parola e del ragionamento il compito di sciogliere e dissolvere la parte fantastica, immaginifica e mitica come Astrea che, ritrovando Celadon dopo averlo creduto annegato, preferisce pensarlo come il fantasma del suo corpo errante, tanto che alla fine, una volta rivelati tutti gli inganni e i mascheramenti, gli griderà contro entusiasta “Rivivi Celadon, rivivi!”. La dicotomia tra pensiero razionale e fantasia, tra vita reale e la proiezione di un’esistenza nel ricordo dei propri desideri, è presente sullo schermo nelle perfetto equilibrio con cui coesistono immagini e parole.
Sono le immagini a portarci in quei luoghi della Francia ormai distrutti e invasi dalla modernità, come ci avvisa la didascalia iniziale, e che qui sono reinventati da un’altra parte, perduti e, per forza di cose, pensati attraverso il testo di D’Urfè, ma è la parola che dà uno spessore, una dimensione reale a corpi e voci, rendendo le bizze e i capricci degli innamorati qualcosa di aulico, distante, sospeso in un tempo remoto eppure il loro sentire svincolato dalla necessità del chiedersi il quando e il dove ma soltanto il come.
Il cinema di Rohmer è profondamente appartato e unico, di un’unicità che ferma questo tempo, permette allo spettatore di crearsi una dimensione alternativa e consumare questo inalterato gusto della visione che non impone, pretende o aggredisce ma avvolge, stordisce, fa perdere la cognizione del tempo che conosciamo. C’è la delicatezza e la grazia che auspica Buckley nel momento della morte, ma nella chiave opposta di celebrazione della vita, dell’assoluteza della vita, dove ogni valore e ogni virtù vengono subliminate in una sorta di Filosofia di vita e, di conseguenza, in Rohmer di cinema.
La scelta di Celadon di continuare a fingersi morto agli occhi di Astrea che, in un momento di rabbia gli aveva ordinato di non farsi più vedere, non è dissimile dalla scelta del Jean-Louis Trintignan de La mia notte con Maud che, in nome della muta promessa d’amore fatta ad una sconosciuta incontrata in chiesa, rinuncia alla possibilità di un rapporto presente, compromissorio con la loquace, reale Maud e la rottura finale dell'”incantesimo” da parte di Astrea tutta incentrata nella scoperta dell’identità fisica di Celadon celato sotto vesti femminili è speculare al percorso di Trintignan che attraverso Maud trasforma la muta promessa d’amore nella realazione autentica, viva, finalmente compromissoria con quella sconosciuta che, oltre alle fattezze, acquista poi anche la voce e la grazia di Marie-Christine Barrault. Solo una sguardo così fluido e carezzevole poteva spingersi in territori tanto lontani e restituirceli così vicini.