 Lo spettatore-tipo di Biùtiful cauntri sa cosa aspettarsi prima ancora di prendere posto in sala. Questo esemplare di spettatore è colto, ben informato, legge i quotidiani e frequenta attivamente blog e forum. E’ solitamente impegnato e ben disposto all’indignazione. In gran parte vota centro-sinistra, ma quando abbassa la guardia o è distratto, subisce talvolta il richiamo del canto del Grillo dell’antipolitica. Si schiera con la magistratura impegnata nella lotta alla corruzione e con ogni probabilità è stato tra i primi estimatori di Gomorra, il libro di Saviano di cui deve aver apprezzato soprattutto la coraggiosa presa di posizione contro l’intrico di crimine organizzato, affarismo e politica.
Lo spettatore-tipo di Biùtiful cauntri sa cosa aspettarsi prima ancora di prendere posto in sala. Questo esemplare di spettatore è colto, ben informato, legge i quotidiani e frequenta attivamente blog e forum. E’ solitamente impegnato e ben disposto all’indignazione. In gran parte vota centro-sinistra, ma quando abbassa la guardia o è distratto, subisce talvolta il richiamo del canto del Grillo dell’antipolitica. Si schiera con la magistratura impegnata nella lotta alla corruzione e con ogni probabilità è stato tra i primi estimatori di Gomorra, il libro di Saviano di cui deve aver apprezzato soprattutto la coraggiosa presa di posizione contro l’intrico di crimine organizzato, affarismo e politica.
Gli hanno detto che il film è sì un pugno nello stomaco, ma che va visto, costi quel che costi. Sulla questione dei rifiuti si sente preparato: non ha perso una puntata sull’argomento, da Ballarò ad Annozero. E’ convinto che le eco-mafie esercitino il pieno controllo sul territorio campano e si preoccupa certamente per le montagne di spazzatura in mezzo alle strade e per la qualità dell’aria alla diossina. Lo spettatore-tipo, dopo ponderate riflessioni, è portato tuttavia a ritenere che le popolazioni locali in rivolta contro discariche e termovalorizzatori, pur mosse da preoccupazioni legittime, pecchino in ultima analisi di egoismo e di irresponsabilità, quando non siano direttamente manipolate dai clan camorristici.
In adesione con le posizioni dei media, vede nel potenziamento della raccolta differenziata una soluzione a lungo termine, ma per l’immediato caldeggia un intervento deciso del super commissario di turno volto alla riapertura dei siti di stoccaggio fatti ostaggio dalla popolazione.
Accettare il sacrificio di pochi per il bene di molti sembra essere la convinzione del nostro spettatore democratico, progressista, responsabile, nel predisporsi ad assistere alla proiezione di Biùtiful Cauntri, documentario di Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio e Giuseppe Ruggiero presentato in anteprima all’ultimo festival di Torino e uscito con fatica da qualche settimana in una manciata di sale italiane.
Bene, ora immaginiamoci in sala accanto al nostro spettatore, di cui condividiamo vagamente, varrà la pena di ammettere, l’orizzonte culturale, un po’ meno le granitiche certezze.
Come ampiamente previsto, la collisione con la materia densa del pattume è violenta fin dalle prime scene, tanto che pare quasi di sentirne l’olezzo. Tutto intorno gabbiani grossi come avvoltoi volteggiano beati su montagne di rifiuti, mentre incontriamo Raffaele Del Giudice, sorta di Masaniello ecologista la cui irriducibile napoletanità emerge tanto nell’inflessione verace che nel temperamento viscerale. In compagnia sua percorriamo le polverose strade dei comuni di Acerra, Giugliano, Villaricca, sulle tracce di certi spaventosi delitti. Ma non di morti ammazzati per mano della camorra si parla qui. I colpi di arma da fuoco dei regolamenti di conti per il controllo del territorio giungono solo come un’eco lontana. La criminalità è capace di cambiare, muta per adeguarsi alle richieste del mercato e può indossare indifferentemente i panni rispettabili della business class o la fascia tricolore del rappresentante dello Stato.
Educatore ambientale e vulcanico attivista di Legambiente nella zona Napoli nord, Del Giudice è prima di tutto uno che ama la sua terra, martoriata da decenni di sistematiche collusioni tra istituzioni, imprenditoria e crimine organizzato e umiliata dalla superficialità di approccio di decenni di scelte politiche poco lungimiranti, ostinato nella sua battaglia quotidiana contro i responsabili e i conniventi dell’apocalisse ambientale.
Lo seguiamo pattugliare in lungo e in largo un territorio che conosce come le sue tasche per verificare, magari a seguito di una segnalazione anonima, la presenza di una discarica abusiva, lo sversamento di rifiuti tossici industriali in un fiume, il mancato rispetto delle misure di sicurezza di un sito di stoccaggio sfoggiato come fiore all’occhiello dalle autorità.
Con conseguenze finalmente sotto gli occhi di tutti: l’avvelenamento delle falde acquifere e dell’atmosfera, dei terreni coltivati o destinati a pascolo; percentuali di sostanze nocive ben oltre i limiti di legge nei prodotti dell’agricoltura, nel bestiame e nei derivati (di queste ore è la notizia che Corea e Giappone avrebbero deciso di sospendere l’importazione della mozzarella di bufala dall’Italia).
Ci troviamo in provincia di Napoli, Italia, Europa, ma la desolazione del paesaggio richiama l’indiana contrada di Bophal, dove ancora, a distanza di 24 anni, perdurano gli effetti devastanti delle scorie della multinazionale Union Carbide, o i dintorni di Seveso negli anni ‘70, o ancora l’indotto dei vari stabilimenti petrolchimici disseminati sul territorio italiano quando, abbagliati dal miraggio dell’occupazione e dello sviluppo ad ogni costo, ci si sperticava in elogi degli effetti salvifici dell’industrializzazione, a tutto discapito della sostenibilità ambientale.
Ci viene subito naturale simpatizzare con questa specie di Micheal Moore nostrano e siamo disposti a fare della sua la nostra causa quando ad esempio, solo contro tutti, cerca di convincere gli ostili vigilantes di guardia a una discarica ufficiale, che i primi a rischiare la salute sono proprio loro, costretti per lavoro a respirare esalazioni nocive senza protezione alcuna. O quando, di fronte a un impassibile Bertolaso, ex-commissario per i rifiuti in visita ufficiale presso il medesimo sito di stoccaggio, Del Giudice ha uno sfogo di rabbia nel segnalare la mancata adozione delle più elementari misure di sicurezza.
Fin qui tutto bene, si direbbe. La macchina da presa e il militante ecologista sembrano uniti nella lotta, sostenendosi reciprocamente in un cammino certamente irto di ostacoli, ma che appare l’unico percorribile verso l’obiettivo di una ritrovata coscienza civile capace di incidere sullo stato di cose esistente. Da una parte il coraggio della denuncia messa in atto da un esponente della comunità locale, dall’altra la cassa di risonanza mediatica offerta dal mondo della cultura: la guardia rimane alta e la speranza non appare come un mero abbaglio.
Il disagio però sopraggiunge quando, via via che la vicenda viene inquadrata nei suoi effettivi contorni, assumendo le proporzioni epiche di un inferno dantesco, perdiamo di vista il nostro Virgilio e la struttura narrativa si polverizza in una pluralità di testimonianze soggettive che ci sommergono con una colata compatta di solitaria e sorda disperazione. 
Da questo punto in poi il documentario segna il passo della denuncia e vira decisamente verso una sorta di autocompiaciuto grido di dolore per lo stillicidio di una cultura contadina millenaria ridotta ad abusiva e maltollerata riserva indiana. Micheal Moore e il documentario d’inchiesta a tesi, sembrano adesso cedere il posto a Pierpaolo Pasolini, nel suo aspetto meno lucidamente militante e più di retroguardia, lirico e programmaticamente anti-moderno.
La macchina da presa indugia con eccessivo gusto del patetico sulle pecore avvelenate dalla diossina e condannate ad essere abbattute, raccoglie testimonianze di agricoltori disperati che mostrano le loro pesche atrofiche e annerite da strati di sostanze tossiche, ma che tenteranno in ogni caso di piazzare sui mercati e forse arriveranno sul
le nostre tavole, previo lifting. E progressivamente tutta la rabbia che ci cova dentro, anziché esplodere e suggerire la rivolta morale, si coagula e ci paralizza, rendendoci muti testimoni di un disastro senza veri colpevoli – perché tutti colpevoli in un modo o nell’altro – e senza vie d’uscita. Quasi un condanna del destino, una via crucis di cui anche la musica raggelante sembra scandire le stazioni.
E a nostro avviso non basteranno né i brandelli di intercettazioni telefoniche in cui pur emerge chiaramente il rapporto di connivenza tra imprenditori del nord e la malavita locale, né l’intervista a un magistrato esperto di ecocrimini, a far riguadagnare al film di Calabria e compagni il terreno perduto e auspicato della riflessione politica e della denuncia circostanziata di responsabilità individuali o di gruppi di potere. Anzi, nell’economia stilistica del documentario, dal respiro consapevolmente poetico e cinematografico, simili espedienti appaiono stridenti concessioni al linguaggio piatto e giornalistico dell’inchiesta televisiva.
Come proiettati in un film anni ’70 del genere apocalittico fine-di-mondo, ci imbattiamo negli ultimi sopravvissuti di una civiltà al crepuscolo, estremi rappresentanti di un’umanità decimata da indicibili eventi avversi.
Questi ‘ultimi uomini sulla terra’, contadini e allevatori, popolano gli spazi liminari dell’iperrealtà della società del consumo. Una no man’s land postindustriale, un ‘isola di cemento ballardiana, nascosta alla visuale del ‘mondo di sopra’ dalle quinte scenografiche di calcestruzzo dei muri di cinta degli stabilimenti chimici, dalle precarie barriere di ecoballe stoccate alla rinfusa, attraversata dai piloni di colossali svincoli autostradali.
E’ sempre la vecchia storia del colonialismo che si ripete. Un territorio con una secolare vocazione agricola strappato a tavolino dalle mani dei suoi legittimi abitanti per diventare la più grande pattumiera dell’Europa occidentale.
E’ naturale allora che si respiri rassegnazione tra questi contadini e pastori abituati da secoli a chinare la testa e ad accettare decisioni prese dall’alto e altrove. Ma se è perfettamente comprensibile la rassegnazione di una popolazione a cui mancano i minimi strumenti culturali per mettere le basi di una qualche resistenza collettiva organizzata, è meno accettabile a nostro giudizio che il documentario, aderendo in maniera troppo viscerale alla materia narrata, rischi di sprigionare la medesima rabbia impotente.
L’aspetto parzialmente irrisolto del documentario di Calabria, D’Ambrosio e Ruggiero sta proprio nel rifiutare la scelta netta, cercando un difficile punto di equilibrio tra l’andamento cronachistico e il compiacimento estetico decadente, tra la ricostruzione investigativa e il diario personale, tra la dimensione politica e il dramma individuale.
Biùtiful cauntri raccoglie coraggiosamente indignazione e sdegno ma rischia di sperperarne il potenziale affermativo di denuncia civile presentando una condizione di degrado talmente endemica e radicata, e l’ingarbugliata trama di affari e malaffare impenetrabile a tal punto, da far apparire ogni prospettiva di intervento contro il sistema dello smaltimento criminogeno dei rifiuti come una lotta impari, donchisciottesca, e il nemico da combattere come una sorta di moloch spietato e sostanzialmente invincibile.
Sarebbe ingeneroso affermare che il film, il quale ha l’indubbio pregio di svincolarsi dall’attualità più superficiale dell’emergenza rifiuti, perda del tutto l’occasione di tentare di risalire alle radici del problema lungo la catena delle responsabilità – alcuni nomi e circostanze emergono senza dubbio – ma la sensazione è che, indugiando sul punto di vista delle vittime prevalga la sorda rassegnazione, categoria esistenziale propria dell’indole di una terra e di un popolo abituati da sempre a sopportare e a subire. Commuove certamente la morte di una terra e suscita rabbia la sua quotidiana violazione, ma se l’indignazione e l’insofferenza non si trasformano in sprone alla trasformazione dell’esistente, se la rabbia non è canalizzata verso il raggiungimento di obiettivi seppur minimi di cambiamento, la resistenza civile non trova le condizioni per un vero radicamento e, una volta spenti i riflettori, torniamo tutti come quelle pecore di in un gregge malato.
P.S.Un’ultima domanda, palesemente retorica, viene spontanea dopo aver visto Biùtiful cauntri nell’unica ostinata sala romana che lo tiene in programmazione: per quale motivo si sia costretti ad acquistare un biglietto per assistere alla proiezione pomeridiana in un minuscolo cinema dall’altra parte di Roma, anziché avere l’opportunità e il diritto di vederlo inserito nel palinsesto di una delle reti del servizio pubblico, magari in prima serata. Ben coscienti che, dove non può attuarsi direttamente la censura politica, arriva quella ben più subdola del mercato, a stritolare la distribuzione dei prodotti più anomali e inclassificabili.
Se ti è piaciuto quello che hai letto, perché non lo condividi?



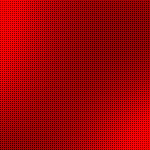





mah… le riflessioni di sergio ponzio mi son piaciute, ma purtroppo credo che questa storia andasse raccontata così.il non riuscire a canalizzare la rabbia e a trasformarla in ribellione non dipende dal racconto, ma dalla situazione,chiunque sia napoletano capisce di cosa parlo. l’unica cosa che si può fare riguardo la camorra e la morte della terra campana è informare, conoscere e diffondere ciò che avviene, ma nessuno speri di cambiare qualcosa. se di realtà parliamo, allora è bene non farsi illusioni. chi non vive in quei luoghi non può sapere. questo documentario è lo specchio di questa realtà. e purtroppo tutto soffoca…
ringrazio per aver apprezzato le riflessioni e capisco bene il punto di vista del cittadino napoletano che si sente impotente, tuttavia resto convinto che una mobilitazione della società civile accompagnata da una campagna di informazione puntuale potrebbe lavorare al cambiamento e intaccare il sistema delle connivenze e dei privilegi. altrimenti, se si pensa che tanto nulla potrà mai mutare, che senso avrebbero l’informazione e la denuncia? tanto varrebbe consegnare le chiavi della campania alla criminalità organizzata e trovare una nuova terra promessa
il senso di impotente rivolta, che alla lunga può portare all’indifferenza, lascia tramortiti, è vero, ma quello che mi è parso importante, in questo documentario, è il tentativo di raccontare la realtà in modo diverso tanto da quello televisivo quanto da quello dei documentari d’inchiesta, lasciando all’ambiguità e alla potenza evocativa delle immagini la parola. A noi, poi, costruire il presente attarverso riflessioni e discussioni. Ieri in un documentario cileno intenso e bello, Calle Sante Fè, un’esiliata ex militante nel MIR diceva che la ricostruzione della memoria storica la si fa fondamentalmente con le conversazioni. Mi tira su.